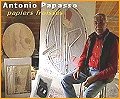 |
 |
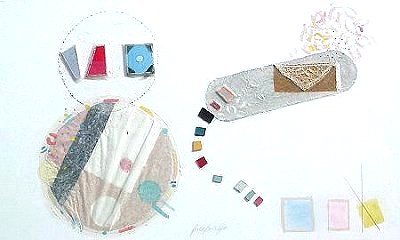 Si sono fatti nomi, sono state citate tendenze e poetiche
nel tentativo di spiegare la pittura di Antonio Papasso: e in
ognuna delle esemplificazioni il motivo di fondo sul quale i
vari passaggi si andavano organizzando (anche tecnicamente)
sembrava accerchiato, sempre più avvicinato, ma per
oscillazioni, quasi che la più segreta natura di una
ricerca tutto sommato coerente non si lasciasse affrontare per
definizione diretta.
Si sono fatti nomi, sono state citate tendenze e poetiche
nel tentativo di spiegare la pittura di Antonio Papasso: e in
ognuna delle esemplificazioni il motivo di fondo sul quale i
vari passaggi si andavano organizzando (anche tecnicamente)
sembrava accerchiato, sempre più avvicinato, ma per
oscillazioni, quasi che la più segreta natura di una
ricerca tutto sommato coerente non si lasciasse affrontare per
definizione diretta.
Che la zona in cui Papasso si muove sia - genericamente -
quella dell'informale è indubbio, ma con connotazioni
assai particolari. È il momento della chiarificazione non solo
tematica direi che debba essere individuato attorno al tempo, e
al titolo, delle "genealogie".
È qui, credo, che Papasso libera con sempre maggiore
consapevolezza motivi interiori e metodologia conpositiva,
facendo coincidere intenzioni e risoluzioni.
Nel separare la campitura dal segno, nel rinunciare alla
forte propensione lirica ma non scartando nemmeno
l'interferenza
dell'inquietudine, in altre parole accettando come necessaria
(in termini dialettici) la messa in discussione di una
eventuale nostalgia estetizzante attraverso la persistenza di
un malessere diffuso non ancora evidenziato ma pressante (come
accade in ogni meccanismo di attrazione e ripulsa, di
liberatorio abbandono e resistenza e rifiuto del processo di
analisi di una condizione) Papasso distingue,
nell'informalità vagamente panteistica della sua opera
precedente, il rappresentativo (la suggestione emotiva) e la
struttura affidando al rappresentativo i colori e le materie,
che restano indizio di affettuose tenerezze, allusioni ad una
condizione pacificante liricamente tradotta, ma lasciando alla
nervosità del segno, quasi una scrittura automatica, il
compito di sensibilizzare, o perfino "irritare" le forme.
Per
questo le opere più recenti di Papasso si presentano
così ambiguamente, esponendosi, da un lato, come esempi
di una variazione dell'informale e, dall'altro, per una sottile
e tuttavia difficilmente negabile tensione narrativa
(articolazione di un "discorso" tutto interno, esposizione di
una tesi: quella delle "genealogie", processo di
proliferazione, di continua nascita, di ciclicità anche
rituale sottolineata dal fare creativo), come esempi di una pittura che si offre
come pagina leggibile e insieme come metodo di lettura, non
escludendo qualche correlazione di tipo surreale.
Roberto Sanesi(*)

|
Roberto Sanesi (Milano 1930-2001). Poeta e critico italiano. Studioso di letteratura anglo-americana (Poeti americani 1900-1956, 1958; Dylan Thomas, 1966; La valle della visione, 1985), ha svolto intensa attività di traduttore (J. Milton, W. Blake, Th. S. Eliot) e ha tradotto antologie della poesia inglese del Seicento e del Novecento. Numerose le raccolte poetiche. |